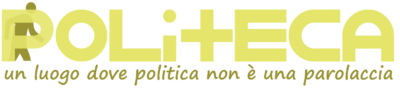11 settembre 2001 – 2018: UN BILANCIO
L’attacco agli Stati Uniti d’America dell’11 settembre 2001 ha avuto un indubitabile successo.
Ha avuto successo perché ha attirato verso il terrorismo jihadista un gran numero di giovani, provenienti principalmente dal mondo islamico ma non solo. La chiamata al martirio del fu-Califfato di Abu Bakr Al-Baghdadi ha avuto un riscontro impressionante: dai quattro angoli del mondo migliaia di ragazze e ragazzi sono giunti in Siria ed in Iraq; centinaia si sono suicidati per il trionfo della “santa causa del vero-Islam” contro un occidente malato, corrotto, diabolico; il terrorismo di matrice jihadista si è inoltre espanso in tutto il globo: ovunque sono nati gruppi e cellule pronte all’attacco.
Il terrorismo pseudo-islamico non sarebbe durato così a lungo, non si sarebbe rafforzato così tanto, non avrebbe dimostrato una così formidabile resilienza agli attacchi che l’occidente, ma non solo, gli ha portato in questi 17 anni, se non fosse un fenomeno sociale rilevante.
Siamo dunque di fronte ad un fenomeno sociale e i fenomeni sociali non si battono con le sole azioni militari.
Formazioni come Al Qaida o l’ISIS non sono derubricabili ad organizzazioni criminali finanziate da questa o quella potenza, utili a questa o quella strategia, o comunque non sono solo questo: esse sono anche – e soprattutto – portatrici di un’ideologia, di una cultura, di una teoria. Una nuova idea ed un nuovo metodo si sono palesati agli occhi del mondo il giorno 11 settembre 2001 e questa idea, questo metodo,hanno fatto fin qui molti progressi.
In questi 17 anni “la lotta al terrorismo” dell’occidente si è dimostrata, per molti aspetti, fallimentare.
L’intervento in Afghanistan era difficilmente evitabile. Un Paese di notevoli dimensioni che importava miliziani e petro-dollari wahabiti ed esportava terrorismo andava in qualche modo fermato. L’azzardo era grande, l’impegno avrebbe dovuto essere fortissimo. Si noti bene: non si parla del solo impegno militare, ma anche di impegno sociale: in parole povere di spendere un sacco di soldi per riorganizzare il welfare tra quelle popolazioni e di avere solidi mediatori culturali nel rapporto con le tribù. Nulla ha funzionato.
La presunzione tecnologica ha fatto dimenticare la necessità del numero. Per pacificare un Paese servono uomini, tanti uomini, sul terreno; ma il primo prevalere sulle forze Talebane ha immediatamente indotto l’occidente a cantare vittoria e a diminuire drasticamente il numero dei soldati in quel Paese.
Forse questa fretta nel diminuire le truppe era anche legata alla tenuta dell’opinione pubblica occidentale. Un’opinione pubblica che urla, piange, s’indigna e reagisce con rabbia ed orgoglio agli attentati, ma che si rivela poi poco propensa a pagare il prezzo di una guerra campale. Un prezzo che èfatto di tasse più alte e di figli ritornati nelle bare.
Mettere in secondo piano la tutt’altro che vinta guerra in Afghanistan per invadere l’Iraq nel 2003 è stato il colpo che ha spento tutte le candele. Dopo 17 anni di guerra l’Afghanistan è un altro vietnam perduto ed al-Qaida è ancora lì, viva, vegeta e organizzata. E noi non si sa più che pesci pigliare.
L’invasione dell’Iraq del 2003 è stato il più madornale errore che si potesse fare. Un errore che ci è costato disastri immani e che lascerà per decenni una scia di dolore e di sangue in giro per il mondo. Per fare la lotta ad Al Qaida, cioè ad un’organizzazione asimmetrica transnazionale, si è invaso uno stato nazionale, governato da un dittattore che era un nemico mortale di Osama Bin Laden. La logica sta altrove.
Si è invaso l’Iraq a causa del possesso di armi di distruzione di massa che poi non sono mai state trovate, la qual cosa è stata poi candidamente ammessa; ma ormai – da cosa nasce cosa – eravamo lì, e a nessuno è venuto in mente, non dico di ritirarsi, ma anche solo di chiedere scusa. La credibilità dell’occidente agli occhi del resto dell’opinione pubblica mondiale è così sprofondata ai minimi livelli.
Ma soprattutto l’invasione dell’Iraq ha riaperto il Vaso di Pandora: ha riacceso la secolare lotta tra l’Islam sunnita e l’Islam scita.
Era assolutamente prevedibile – anzi, era certo – che sarebbe accaduto. Tutti i disastri successivi: la potenza maturata dall’ISIS, l’emergere dell’Iran come grande attore regionale, la guerra di Siria, le ondate di profughi e di terrorismo che hanno sconvolto l’Europa, sono figlie di quella scelta scellerata.
Mi sono chiesto, senza trovare una risposta certa, se la scelta dell’amministrazione Bush Junior fu dettata da semplice stupidità o dalla criminale e fallimentare idea di provocare un gigantesco vietnam in medio-oriente per poi arrivare e raccogliere i cocci, a cose fatte, ergendo gli USA a salvatori (ma soprattutto a “protettori”) di quei Paesi distrutti.
Comunque sia non è andata così: se la politica estera americana degli ultimi 15 anni era volta a rafforzare il terrorismo, la Russia e l’Iran in medio-oriente, allora possiamo dire che il risultato ottenuto è perfetto. Altrimenti bisognerebbe ammettere che gli USA hanno sbagliato tutto.
La Libia è un altro esempio di un disastro creato dall’incapacità intellettuale dell’occidente. Chi vi scrive di questo errore ha fatto parte. Personalmente ero d’accordo con Bernard-Henri Lévi quando parlava di “diritto all’intervento umanitario in Libia”. Niente di più sbagliato. Non si è compreso che – ad eccezione della Tunisia – i Paesi medio-orientali sono attualmente poco, o per nulla, adatti a forme di ricostruzione democratica post-dittatura. Gli attori che hanno contato nelle primavere arabe sono stati tre e tre soltanto: l’uomo della strada, i militari, la Fratellanza Musulmana e/o la galassia Salafita. C’erano anche settori dell’opinione pubblica di orientamento democratico ma i loro esponenti sono stati fatti fuori – uccisi – quasi subito.
Due sono le regole culturali che fanno una democrazia: 1) in democrazia non ci si pesa, ci si conta; 2) in democrazia chi vince non “prende tutto”, una parte del potere deve rimanere nelle mani di organismi autonomi (magistratura, corte costituzionale, banca centrale ecc…) e l’opposizione ha il diritto di far sentire la propria voce. Se in un qualsiasi Paese manca questa cultura di fondo è inutile fare le elezioni e creare un parlamento; quelle elezioni, quel parlamento, non saranno altro che il guscio vuoto della democrazia e non dureranno: la parola passerà presto, nuovamente, al fucile. Lo si è visto con le elezioni palestinesi e con le elezioni egiziane, e l’attuale incapacità del parlamento iracheno a formare un governo non dice nulla di buono. L’occidente (forse) sta imparando in Libia, a proprie spese, quanto sia inutile abbattere una dittatura (o una monarchia, o una teocrazia) se in sua sostituzione non c’è altro che il caos. È questo il paradigma dell’intervento occidentale di questi anni nel grande medio oriente, fin qui non è stato prodotto altro che caos, ed in quel caos le forze che hanno compiuto gli attentati dell’11 settembre prosperano.
Che facciamo? Non ho qui la presunzione di essere esaustivo. Anzi, mi limiterò ad una sola cosa, una cosa che proprio non dobbiamo fare: non dobbiamo destabilizzare il grande medio-oriente. È già abbastanza destabilizzato di suo. Questo è un passo fondamentale: le formazioni terroristiche attecchiscono più robustamente nei Paesi dove ci sono conflitti in corso.
Le potenze devono evitare d’ora in poi i conflitti per interposti eserciti. Una potenza mondiale, quando vede la potenza avversaria coinvolta in una guerra di usura, deve evitare la tentazione di “prolungargli il vietnam” sostenendo le forze che gli si oppongono. È stato in questo modo che l’occidente si è covato in seno Al Qaida prima e l’ISIS poi.
L’occidente deve resistere alla tentazione di esportare la democrazia in Paesi che a quella forma di governo non sono culturalmente preparati. Per quanto possa essere duro vedere scorrere il sangue ora sappiamo con ragionevole certezza che non è con le baionette che si esporta la democrazia: il nostro intervento – per quanto bene intenzionato – potrebbe farne scorrere ancora di più, e più a lungo.
L’occidente non deve stringere, né sostenere, alleanze politico-militari con Paesi complici o comunque tolleranti dell’estremismo jiadista.
Almeno questo, almeno non facciamoci male con le nostre stesse mani.
Sono fiducioso sull’esito finale di questa lunga guerra che ci oppone ai macellai pseudo-islamici. Anche se penso che in questo momento questa guerra la stiamo perdendo, penso anche che il mondo civile alla fine prevarrà. Penso che riusciremo a prevalere perché – grazie a Dio – siamo tutti, fondamentalmente, una banda di miscredenti, anche la maggior parte di quelli tra noi che vanno in chiesa o alla moschea o quant’altro. E l’Occidente è il portabandiera di questa diffusa mancanza di fede e di eroismo. Siamo individualisti ed egoisti, teniamo a viver bene, teniamo famiglia, teniamo un appuntamento telefonico, i preti delle confessioni cristiane non provano più a dirci che dobbiamo riconquistare Gerusalemme e convertire tutti gli arabi alla Santa Fede: li prenderemmo per matti. I nostri giovani – grazie a Dio – pensano molto di più all’amore, o – al minimo – a scopare, di quanto pensino ai Sacri Destini dell’Umanità. Tutto questo è salutare, tutto questo è portatore di una pace relativa. Parafrasando Henri Lévy: “per una pecora rubata ammazzi al massimo quattro o cinque persone. Per facilitare l’avvento del Regno di Dio, o della Virtù, o del Reich Millenario, o del Paradiso dei Lavoratori, fai delle stragi di proporzioni orrende”. Ecco, individualismo e un po’ di benessere: questa è la nostra idea, questo è il nostro progetto, questo è il nostro soft-power. Ed è un progetto ragionevole, utile, pratico, di successo.
Per quel poco che sono andato in giro – da Cuba alla Tanzania, dalle Filippine all’Indonesia – ho visto questo modesto ideale di vita occidentale farsi largo, ho visto tanta gente darsi da fare per comprarsi una casa, un frigo, una televisione, un abbonamento alle partite di calcio, un vestito carino per i bambini. Questa benefica volontà diffusa di vivere individualmente meglio non si può fermare. Per questo sono fiducioso sul fatto che questa guerra – a gioco lungo – la vinceremo noi.